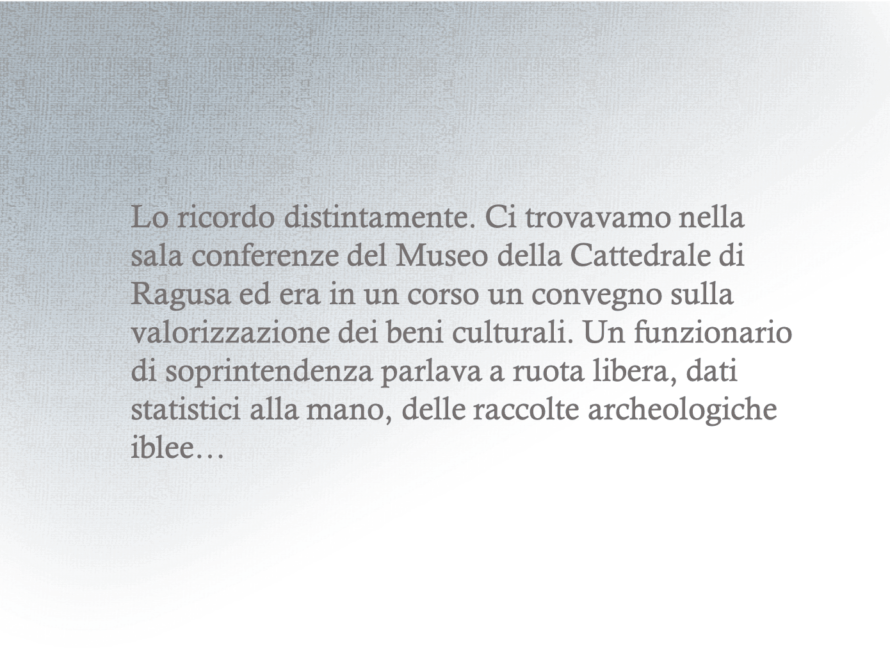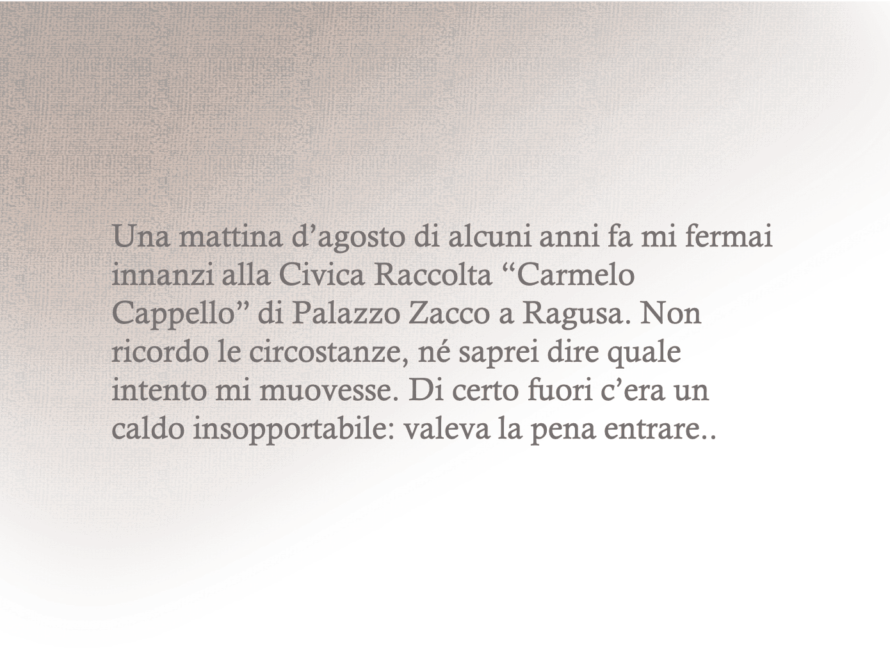La aveva simulata così tante volte, la morte, che ci eravamo convinti si fosse immunizzato. Così non è stato. La morte infine è giunta, dopo oltre un mese di lotta, per una puntura di zanzara. Sì, avete capito, Momò Calascibetta, l’artista che ha trascorso gli ultimi anni a punzecchiare i potenti dell’arte, ha subìto il medesimo destino: l’elefante è stato atterrato da un minuscolo anofele, che gli ha contagiato il virus del Nilo Occidentale. Adesso che il respiro dell’uomo si è spento, la sua pittura andrà colta, mi auguro, in una prospettiva più pacata. I riferimenti a persone o situazioni reali, che tanti problemi avevano creato all’artista in decenni di carriera, perdono infatti, in sua assenza, ogni interesse. Solo il messaggio rimane: una critica serrata, senza peli sulla lingua, alle storture di un mondo i cui protagonisti – da un lato gli artisti; critici, galleristi e curatori dall’altro – gli apparivano animati da interessi contrastanti; i primi concentrati – sovente con l’aiuto di pesanti paraocchi – sul successo di un momento; i secondi sui “classici”, o sul nuovo: in una parola, sul prodotto più vendibile, più gradito al mercato. Come l’artista mi ha più volte ripetuto, le opere maturate nel tempo, così necessario a chi pratica onestamente il suo mestiere, si sono fatte oggidì sempre più rare. E se non si trova il tempo per creare qualcosa di importante, che cosa, eccetto il profitto, conta? Quale opera concepita in questo modo ha speranza di durare? Si capisce come un ambiente simile – quello che oggi chiamiamo “sistema dell’arte” –, indigente non tanto per mancanza di soldi quanto per assenza di valori, sia divenuto l’obiettivo pressoché unico del sarcasmo di Calascibetta. Che lo ha identificato, a ragion veduta, con la sua terra natale; in gran parte dei suoi dipinti, dal carnevale sfrenato di Comiso Park che tanto piacque a Bufalino, alla Fontana della Vergogna, su cui ha scritto una pagina memorabile Philippe Daverio, alla prima parte di Cenere all’estremo Festino, Ultima Cena tragicomica senza tavolo e senza vino, la Sicilia è sempre stata il bersaglio preferito del suo amore. Una Sicilia, intendiamoci, del tutto immaginaria. Il potere dell’arte – lo ha scritto Simon Schama – è quello “della sorpresa che disorienta”. Persino quando sembra mimetica, essa non riproduce la familiarità col visibile: non è un’estetizzazione né, tanto meno, un’inchiesta. L’arte è una realtà nuova, a sé stante, che procede in modo autonomo. L’artista, è chiaro, filtra le informazioni che il libro della natura e gli occhiali della cultura gli trasmettono – la pittura di Momò, ad esempio, sarebbe incomprensibile tanto privandola dei riferimenti alla Sicilia quanto dei molteplici spunti che la allacciano a Dix, a Grosz, a Crivelli, a Mantegna, ma pure a Fellini, a De Sica, a Truffaut, a Pasolini, via via a scendere sino al Kamasultra di Jacovitti, ai disegni di Kentridge o alle foto di LaChapelle – e le rimpiazza con una creazione originale. Sua missione, oltre a stordirci di bellezza, è terremotare il banale. Renderci partecipi di un dramma: la tragedia dell’uomo artista che, sotto la spinta di una pressione estrema, si è deciso a intraprendere l’impresa della vita. Opere come il Giardino delle delizie – una riscrittura in salsa sicula, con tanto di ape car guidata da Antonello da Messina falso invalido, del capolavoro di Bosch – in cui l’autore, pur non essendo direttamente presente in forma di ritratto, sorride alle spalle di ogni singola figura: “In questo mio particolarissimo giardino”, ha dichiarato, “le varietà arboree sono state sostituite dai fantasmi degli individui che mi hanno accompagnato; individui che non hanno mai prodotto frutti, che sono tronchi anemici e bisognosi di fertilizzanti, arbusti aridi e avvizziti nella calura estiva dei Quattro Canti di Palermo; un tripudio umano, uno spettacolo teatrale dove gli attori non devono più fingere un personaggio né seguire un copione, ma limitarsi ad essere se stessi, come ne La classe morta di Tadeusz Kantor. Oggi, ieri, domani; l’alba, il giorno e la notte; passato, presente e futuro; paradiso, purgatorio e inferno convivono nell’opera, sforzandosi di condensare in un istante la vacuità di un’esistenza passeggera”. Ora, lo stile di Calascibetta potrà non piacere, il suo linearismo esagitato e i suoi colori squillanti potranno apparire ai puristi fuori luogo e volgari, ma non c’è dubbio che in questa laica pala d’altare, ambientata nel cuore di Palermo come la Vucciria di Guttuso, egli abbia dato una risposta così esauriente e imponente ai drammi del suo (e nostro) tempo da non essere ripetibile da alcuno: ha vergato una pagina, da consegnare agli annali, della storia dell’arte. Non è quindi vero, come ha scritto di recente Luca Rossi riferendosi a un’opera di Giulio Alvigni presentata all’ultima Art Verona, che la satira sul mondo dell’arte non sia che il “sintomo di un coma profondo”. C’è satira e satira. Il lavoro di Calascibetta, per quanto già esposto in un museo, non si limita a criticare un sistema di cui è parte integrante: lo rivive. La storia è sempre uguale: l’artista è un genio – come Momò ebbe a scrivere di sé giovanissimo, in un diario gelosamente conservato dalla moglie: “Sono un genio, compreso da me stesso” – che si scontra contro padroni ottusi e i loro lacché, i critici pusillanimi e pieni di sé, sino all’inevitabile sconfitta. Cui segue, altrettanto inevitabile, la resurrezione del campione. Accadrà anche stavolta, con l’unica morte reale che tiene dietro, lo dicevo in principio, le cento simulate? Resta quello che lo stesso artista – o chi per lui – ha lasciato scritto perché venisse pubblicato sul suo profilo Facebook, a morte consumata: “Il mio corpo è morto, è cenere, la stessa cenere che mi sono divertito a spargere sul capo mio e di tante altre persone, ma il mio spirito è vivo. Ogni qual volta un mio dipinto vi strapperà una lacrima, un sorriso, una risata amara, io sarò lì con voi. Non ho alcuna intenzione di lasciarvi. Ci sono tante cose che ho ancora da fare: due mostre pronte, un catalogo, una Momografia… Certo non potrò essere fisicamente presente, ma in spirito, ve lo prometto, ci sarò. Questo non è un addio, solo un arrivederci. La vita è bellissima, e gli artisti non muoiono mai”.
Andrea Guastella
(da Andrea Guastella, Attraverso lo specchio)