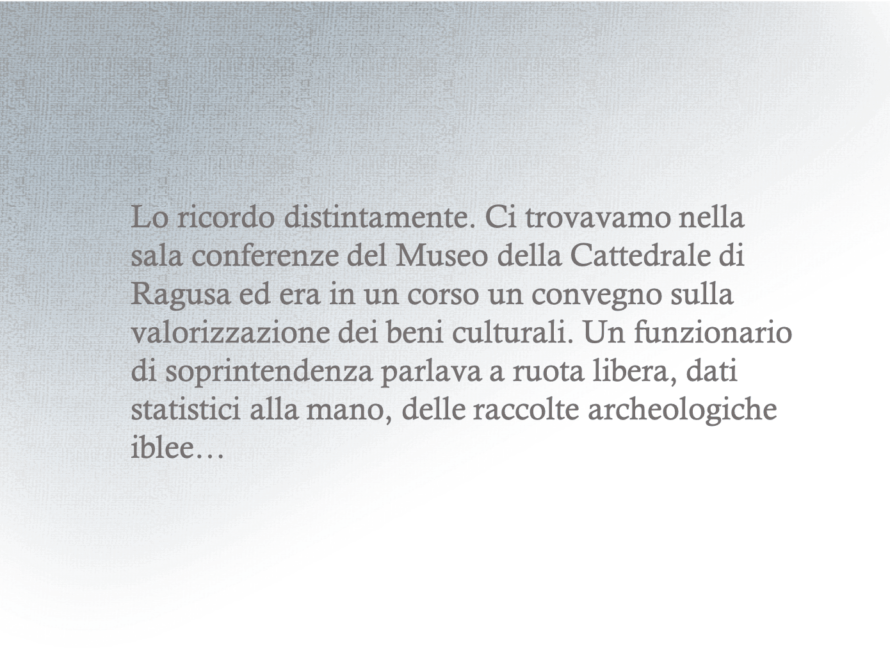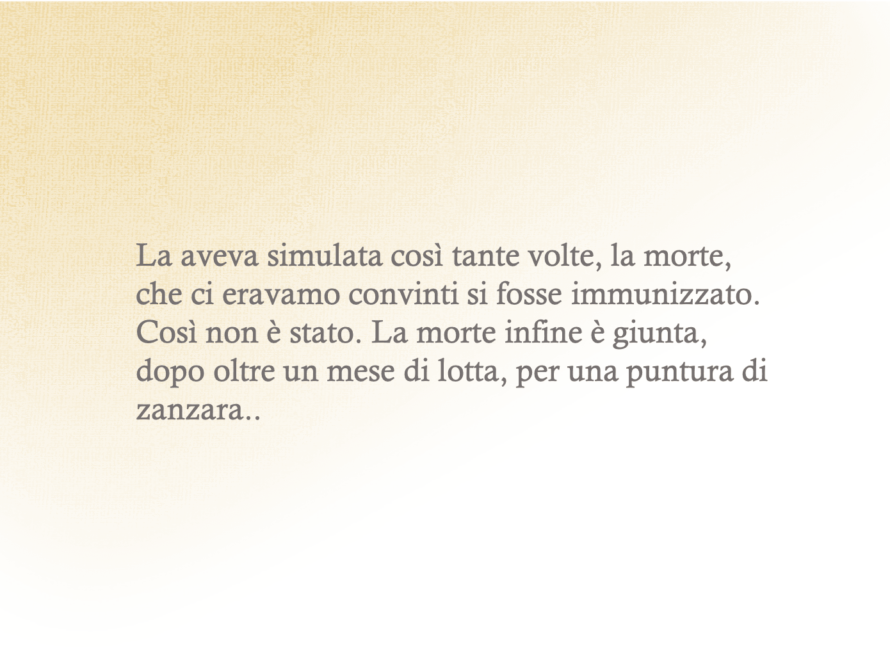Una mattina d’agosto di alcuni anni fa mi fermai innanzi alla Civica Raccolta “Carmelo Cappello” di Palazzo Zacco a Ragusa. Non ricordo le circostanze, né saprei dire quale intento mi muovesse. Di certo fuori c’era un caldo insopportabile: valeva la pena entrare.
Varcata la soglia, esitai. Il palazzo sorgeva nei pressi della mia casa natale, nel centro cittadino, e, recandomi a scuola, lo avevo costeggiato mille volte.
Non avevo mai pensato di visitarlo; e come avrei potuto? Negli anni dell’infanzia l’edificio, dalla facciata cariata e ricoperta di erbacce, mi appariva un ricetto di fantasmi. Gli infissi erano cadenti, le inferriate arrugginite e le strane figure che, con le mensole, reggevano i balconi, erano ceffi di vampiri, evasi dalla cupa Transilvania.
Di abitanti umani, neanche l’ombra; anche se, le sere di primavera, quando il traffico era lì per fermarsi, ero sicuro di udire, accompagnato dal garrire delle rondini, il suono di un pianoforte dolente e appassionato.
Solo una volta avevo sbirciato oltre la porta del palazzo, in occasione di un trasloco, o così avevo creduto. Qualcuno s’era portato via i mobili e, poco più tardi, i mostri della facciata erano finiti tra le sbarre: un’impalcatura annunciava lavori di restauro.
L’ingresso di allora e quello che mi accoglieva adesso non sembravano gli stessi. E non lo erano realmente! I “restauratori” avevano infatti tagliato uno dei rami di una superba scala a forbice, rendendo accessibile un seminterrato, che i custodi del museo mi invitarono solerti ad esplorare.
Accettai. Oltrepassato con disgusto l’osceno montacarichi, mi ritrovai in un dammuso colmo all’inverosimile di oggetti polverosi.
Era il Museo del Tempo Contadino, una raccolta di utensili legati al volgersi del tempo che – a giudicare dal ritmo incalzante dell’esposizione, condizionata dall’angustia dello spazio – sembrava scorresse troppo in fretta: tutto l’opposto dell’enorme tempo dei soggiorni agresti che, con gli insetti assassini e il pulviscolo del grano, mi rendevano insopportabili le estati.
La tentazione di andarmene era forte, ma il sole di più.
Decisi quindi di affrontarlo, il mio peggior nemico: mi incamminai lungo le scale. Che non si rivelarono poi così terribili, non fosse stato per un’istallazione nel mezzanino – la camera da letto dei contadini – che mi parve davvero fuori luogo.
Se gli arnesi da fatica nel basso potevano celare un barlume di senso – simbolico, a dire il vero un po’ classista, della serie “i poveri sotto” –, una mostra nel cuore delle scale era un pericolo mortale. E se la notte, svegliatosi di soprassalto per il passaggio di una moto dalla marmitta contraffatta, uno spettro assonnato, bisognoso del bagno, avesse incespicato sui gradini?
Ma il bello doveva ancora arrivare. L’intero piano nobile risultava occupato da sculture di Carmelo Cappello, straordinario artista ibleo del Novecento: forme lineari anelanti lo spazio riflettevano, in quelle stanze anguste o sovraccariche di tinte, la medesima sorte dei mascheroni dei balconi.
Il cuore quasi smise di pulsare. Era questo, mi dissi, il destino dei sogni: finire prigionieri.
Forse il mio pessimismo era condizionato dal contrasto tra lo scempio presente e lo splendore dei ricordi, ma niente, in quello spazio, aveva l’apparenza di un museo.
Non c’erano guide, luci orientate, pareti divisorie per inquadrare le opere. Non c’era una biblioteca, un bookshop, una sala proiezioni. Non si organizzavano rassegne. Niente di niente.
Quando, tempo dopo, mi fu offerto di rilanciare la Civica Raccolta curando una serie di mostre temporanee, le sale mi apparvero sotto una luce nuova.
L’allestimento era ancora dilettantistico, gli ambienti inadeguati ma, complice il coinvolgimento nell’impresa, mi mostrai disponibile ad accogliere l’osservazione di un amico: le ruote dei carretti non erano poi così diverse dalle ultime sculture di Cappello.
L’astrazione, svuotando l’arte della componente umana, in maniera che l’arte restasse arte soltanto, la avvicinava alle forme dei manufatti artigianali.
Il Museo del Tempo Contadino rivelava, in altre parole, il sostrato terroso di cui i semi contemplativi di Cappello si nutrivano.
Peccato, pensai, che i germogli, in quel vaso troppo stretto, soffrissero le angosce dei bonsai.
Peccato soprattutto che il rapporto tra cultura “alta” e “bassa” venisse espresso solo occasionalmente e in modo involontario.
Era un problema antico e serio. Da sempre gli Iblei sono i colli felici del miele e dell’olio: i maggiori poeti, da Ovidio a Tasso a Shakespeare, li esaltano, ma solo a patto di cristallizzarli in questo schema.
Eppure doveva esserci, da qualche parte, un ponte, un anello di congiunzione tra la fantasia e il reale.
Mi ricordai di un antenato, Serafino Amabile Guastella, che descriveva i “villani” – senza di loro ci sogneremmo il “miele ibleo” – in chiave realistico-sociale.
Guastella era un punto di partenza letterario; ma le altre arti? Possibile che la pittura, la musica, il teatro ignorassero del tutto l’Homo Hyblaeus?
La risposta, a meno di non imbalsamare i visitatori locali – soluzione praticabile, data la relativa rarità – non risiedeva in quel museo-contenitore. Ci voleva un contesto culturale. Che trovai, per mia fortuna, nella dimora di un collezionista modicano.
Qui, tra libri e dipinti accatastati, giganteggia una tela di Enrico Maltese, La Festa del Patrono a Modica (1884): rappresenta la processione di San Pietro, con tanto di banda e confraternite a gonfaloni spiegati, durante una sosta presso la chiesa del Carmine.
Sua peculiarità è di riprodurre così puntualmente i fedeli convenuti – chierici, signori, contadini in abito della domenica – che un bel giorno i congiunti di un devoto che aveva posato in prima fila per la “festa”, passato a miglior vita, si presentarono a casa del collezionista per riconoscere il volto dell’estinto e mostrarlo ai nipotini.
Maltese aveva ritratto un uomo. Anzi ne aveva ritratti tanti, a giudicare dai profili di villani che tappezzavano lo studio del mio ospite e che, mi spiegò quest’ultimo, il pittore aveva ideato come figurini di scena per Maruzza (1894), opera lirica di Pietro Floridia ambientata “in Modica e nei dintorni, nell’estremo mezzogiorno della Sicilia”.
Non solo Maltese, dunque, ma un musicista di fama almeno nazionale si era interessato alle vicende dei massari, guardandosi dal rivestirli con gli abiti dei vinti del Verga o del Pitrè: i suoi contadini erano gli stessi, dignitosi e volitivi, incontrati da Guastella nelle sue Parità (1884).
Gente comune, per carità, ma dotata di virtù straordinarie, se si pensa che, come ha notato di recente Dario Adamo, la canzone di sdegno che Peppe intona alla fine del secondo attodi Maruzza rimanda, nel controcanto dei compari, alla pratica della polifonia in accordo, che si credeva estranea al canto popolare, ma che da esso – lo suggeriscono le intenzioni veriste dichiarate espressamente dall’autore – sembrerebbe derivata.
Purtroppo ricerche simili trovano oggi rari appigli nella viva tradizione. Né si può chiedere a un museo di farsi carico di indagini di cui è solitamente, più che il promotore, l’utilizzatore finale.
Ciò tuttavia non toglie che la fruizione pubblica dei disegni e dei dipinti di Maltese, in un allestimento che ne evidenzi l’afflato multiculturale, sarebbe auspicabile.
Come sarebbe auspicabile che i luoghi espositivi, specie quando si tratta di edifici storici – e Palazzo Zacco è monumento nazionale tutelato dall’Unesco – fossero destinati a usi che esaltino, anziché mortificare, le relative qualità.
Perciò mi sembra vada nella giusta direzione la scelta di accogliere presso la Civica Raccolta mostre dedicate alla ricostruzione dopo il grande terremoto.
A patto, s’intende, di liberare dai legacci le sculture di Cappello e di sciogliere le pillole del tempo contadino in una tazza di latte, o di buon vino.
Non sarebbe il caso, come ho proposto già anni fa, di trasferire la collezione etnografica in campagna, o nei locali adiacenti un notissimo Castello?
Nonostante la confusione dei linguaggi, indotta dalla globalizzazione, renda sempre meno agevole comprenderne l’idioma, l’Homo Hyblaeus non è un reperto, né un mito.
Continua ad abitare, e coltivare, un territorio che, anche nei frangenti più difficili, non lo ha mai disilluso né tradito.
Andrea Guastella
(da Andrea Guastella, Stefano Vaccaro, Viaggio negli Iblei. I luoghi degli scrittori)